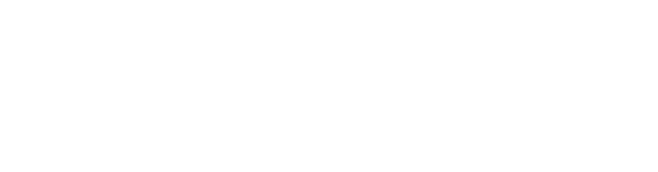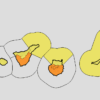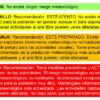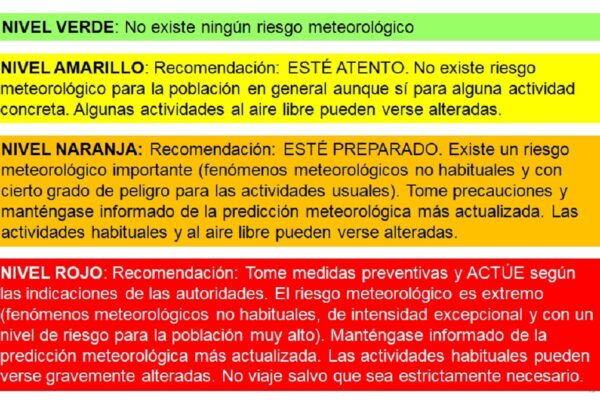La Chiesa Cattolica nelle Isole Canarie: dalla riscoperta all’evangelizzazione
di Alfonso Licata*
L’interesse e l’influenza della Chiesa cattolica nell’arcipelago canario, a partire dalla riscoperta da parte del navigatore italiano Lanzarotto Malocello nel 1312, furono profondi e multifacettati. Questo evento segnò l’inizio di un’epoca di crescenti contatti europei e, di conseguenza, l’avvio di processi di evangelizzazione e dibattiti sulla schiavitù.
La Chiesa giocò un ruolo cruciale nel plasmare la storia delle Canarie, spesso trovandosi in una posizione ambigua tra la difesa dei diritti umani e la giustificazione della conquista.
Prima della conquista castigliana, le Isole Canarie erano abitate da popolazioni indigene, i Guanches, che vivevano in società pre-statali. La riscoperta di Lanzarotto Malocello nel 1312, che diede il nome all’isola di Lanzarote, segnò l’inizio di un periodo di crescenti contatti europei.
Questi contatti erano inizialmente motivati da interessi commerciali (in particolare per l’orchilla, un lichene tintorio molto pregiato) e dalla cattura di schiavi. In questo contesto, la Chiesa cattolica, pur avendo una dottrina che condannava la schiavitù di cristiani, si trovò di fronte alla realtà di popolazioni “pagane” che venivano asservite.
È importante sottolineare che la volontà di evangelizzare le Canarie non attese la conquista castigliana. Il primo, significativo, tentativo di istituzionalizzare la missione evangelizzatrice papale risale al pontificato di Papa Clemente VI.

Già nel 1344, Papa Clemente VI, con la bolla Tua devotionis sinceritas, manifestò esplicitamente la sua intenzione di evangelizzare le isole. Il 7 novembre 1344, il Pontefice istituì formalmente il Vescovato della Fortuna (Fortunatae Insulae), la cui sede era teoricamente stabilita sulle isole, anche se la sua effettiva giurisdizione e operatività erano ancora molto vaghe.
Per ricoprire la carica di primo vescovo di questo nuovo vescovato, Clemente VI nominò Frate Bernardo Font, un carmelitano.
Questa nomina, sebbene non portò a una stabile presenza episcopale immediata sull’arcipelago a causa delle difficoltà logistiche e della mancanza di una base stabile, dimostra la precoce e decisa intenzione della Santa Sede di integrare le Canarie nella struttura ecclesiastica e di avviare un processo di cristianizzazione formale. Questo tentativo, benché fallito nel breve termine, pose le basi per future iniziative missionarie.
La posizione della Chiesa sulla schiavitù nelle Canarie fu complessa e spesso contraddittoria. Se da un lato la necessità di manodopera per le nuove piantagioni di zucchero e per il commercio spinse molti conquistatori e mercanti a ridurre in schiavitù gli indigeni, dall’altro la Chiesa, in particolare il Papato, intervenne in diverse occasioni per condannare e limitare questa pratica.

Diverse bolle papali furono emanate per proteggere i nativi canari dalla schiavitù. Già nel 1434, Papa Eugenio IV emise la bolla Sicut Dudum, condannando la schiavitù dei nativi delle Canarie e ordinando la loro liberazione immediata.

Questa bolla è spesso citata come una delle prime condanne esplicite della schiavitù di popolazioni non cristiane in età moderna. Tuttavia, l’efficacia di queste bolle fu spesso limitata dalla distanza geografica e dagli interessi economici dei colonizzatori.
I missionari, francescani e domenicani in particolare, furono spesso i primi a denunciare gli abusi e la schiavitù perpetrata dagli europei. Essi si fecero portavoce dei diritti degli indigeni, cercando di proteggerli e di evangelizzarli liberamente. La loro azione, seppur non sempre risolutiva, contribuì a creare un dibattito etico e teologico sulla legittimità della schiavitù.
La condanna della schiavitù da parte della Chiesa non era sempre motivata da un’idea astratta di diritti umani come la intendiamo oggi. Spesso era legata alla possibilità di evangelizzazione: se gli indigeni venivano schiavizzati, era più difficile convertirli al cristianesimo. La schiavitù era vista come un ostacolo alla salvezza delle loro anime. Inoltre, la Chiesa voleva evitare che gli aborigeni si rivoltassero contro i cristiani a causa dei maltrattamenti.
L’evangelizzazione fu l’altro pilastro dell’influenza della Chiesa nelle Canarie e fu strettamente legata alla conquista. Per la Chiesa, la conquista era legittimata dalla missione di diffondere la fede cristiana.
A partire dal tentativo di Clemente VI, si susseguirono diverse missioni e la presenza missionaria si fece sempre più consistente.
A seguito dell’interesse commerciale e della necessità di stabilire punti di appoggio, le spedizioni catalano-maiorchine, come quella dei fratelli Bethencourt (non Jean de Béthencourt della conquista, ma precedenti mercanti e navigatori), portarono con sé i primi missionari. Questi primi tentativi furono spesso sporadici e isolati, con scarso successo duraturo nella conversione, ma contribuirono a stabilire un primo contatto.
I francescani furono tra i primi e più attivi ordini missionari nelle Canarie. Essi si stabilirono a Fuerteventura e Lanzarote (le isole più accessibili e con i primi insediamenti europei), cercando di apprendere le lingue indigene e di predicare il Vangelo. Il loro lavoro fu pionieristico, spesso svolto in condizioni difficili e con la necessità di confrontarsi con la diffidenza degli aborigeni e gli interessi dei commercianti di schiavi.
Quando Jean de Béthencourt iniziò la conquista delle Canarie (Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro), la dimensione religiosa era intrinseca al suo progetto. Béthencourt portò con sé ecclesiastici e si adoperò per la costruzione delle prime chiese, come quella di San Marcial del Rubicón a Lanzarote (che fu la prima sede episcopale effettiva nelle Canarie, antecedente a Las Palmas). Questi primi sacerdoti si occuparono dei battesimi dei capi indigeni e dei loro seguaci, spesso come parte di un accordo politico o di sottomissione.
Con la progressiva conquista delle isole da parte della Corona di Castiglia, la presenza di ordini religiosi, in particolare francescani e domenicani, divenne più strutturata. Questi ordini fondarono conventi, scuole e chiese, diventando centri di evangelizzazione e di diffusione della cultura cristiana.
Spesso, l’evangelizzazione avveniva attraverso battesimi di massa, a volte forzati o in circostanze che rendevano dubbia la piena comprensione e l’accettazione della fede da parte degli indigeni. Dopo la conquista di un’isola, la cristianizzazione diventava un obiettivo primario.
L’evangelizzazione portò anche alla soppressione delle pratiche religiose e delle credenze dei Guanches. I loro luoghi sacri furono distrutti o cristianizzati, e le loro divinità furono sostituite con figure cristiane. Questo processo, pur non essendo sempre violento, fu comunque un’imposizione culturale.
Con la conquista di Gran Canaria, fu istituita la Diocesi di Las Palmas de Gran Canaria (1483), che divenne la sede episcopale definitiva per l’intero arcipelago, sostituendo il più teorico vescovato della Fortuna e il vescovato di Rubicón. Questo consolidò la presenza e l’organizzazione ecclesiastica nell’arcipelago.
I conquistatori stessi spesso agivano come agenti di evangelizzazione, seppur con metodi che andavano dalla persuasione alla coercizione. La conversione al cristianesimo era un prerequisito per l’integrazione nella società coloniale e per godere di certi diritti.
L’influenza della Chiesa nelle Canarie fu quindi un’arma a doppio taglio. Da un lato, essa cercò di mitigare gli eccessi della conquista e di proteggere gli indigeni dalla schiavitù, affermando principi che, seppur non sempre applicati, rappresentarono un’anticipazione di concetti moderni di diritti umani. Dall’altro lato, la Chiesa fu un pilastro fondamentale della legittimazione ideologica della conquista, fornendo una giustificazione religiosa all’espansione europea e alla sottomissione dei popoli non cristiani.
L’evangelizzazione, pur mirando alla “salvezza delle anime”, contribuì all’assimilazione culturale e alla perdita delle tradizioni e delle identità indigene.
La Chiesa, in definitiva, si trovò a navigare tra la sua missione spirituale e le realtà politiche ed economiche della colonizzazione, lasciando un’impronta indelebile nella storia e nella cultura delle Isole Canarie. La lungimiranza di Papi come Clemente VI nel tentare di stabilire una presenza ecclesiastica e missionaria dopo la riscoperta di Malocello, dimostra una chiara visione della cristianizzazione come parte integrante dell’espansione europea.
*Presidente della Societaà Dante Alighieri-Comitato Isole Canarie
*Presidente del Comitato Internazionale del VII Centenario della riscoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie da parte del navigatore italiano Lanzarotto Malocello
*Corrispondente Consolare d’Italia a Lanzarote
Testo in lingua spagnola: Del redescubrimiento a la evangelización